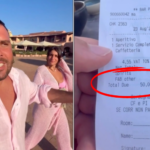La chiesa del Gesù Nuovo è uno dei maggiori luoghi d’interesse di Napoli. Situata nella splendida piazza del Gesù, è nata nel Cinquecento come dimora della famiglia Sanseverino. Fu poi acquistata nel 1584 dai Gesuiti, che incaricarono gli architetti Pietro Provedi e Giuseppe Valeriano di farne una chiesa. Nel 1750 la Chiesa del Gesù Nuovo fu inaugurata e ancora oggi è conosciuta per i suoi splendidi interni barocchi e per essere il luogo di sepoltura di San Giuseppe Moscati, cui sono attribuiti molti episodi di guarigioni miracolose.
La facciata del Gesù Nuovo è certamente l’elemento che salta di più all’occhio, poiché è composta di blocchi di piperno disposti secondo la tecnica del bugnato a punta di diamante (sovrapposizione di blocchi di pietra lavorati in modo che ogni blocco risulti aggettante), immagine che nel complesso risulta impressionante. È proprio la facciata però a nascondere un mistero, svelato negli scorsi anni dallo storico dell’arte Vincenzo De Pasquale.
Nel 2005 De Pasquale, assieme al collega Salvatore Onorato, ha notato che alcuni dei blocchi che componevano la facciata presentavano dei segni. Alcuni architetti e storici dell’arte prima di lui avevano dedotto che i simboli indicassero le cave da cui ogni singolo blocco era stato preso, ma indagando più a fondo De Pasquale ha scoperto che secondo alcune leggende popolari i segni sarebbero simboli protettivi che la stessa famiglia Sanseverino avrebbe fatto incidere dai maestri pipernai. Secondo altre versioni il palazzo sarebbe in qualche modo maledetto, complici i numerosi cambi di proprietario che lo hanno caratterizzato.
I due studiosi però hanno deciso di mappare i simboli e la loro posizione sulla facciata dell’edificio e in questo modo hanno scoperto che i segni fanno parte dell’alfabeto aramaico, lingua semitica nata circa tremila anni fa e parlata in Palestina ai tempi di Cristo. Le lettere incise sui blocchi della facciata sono sette, collocate in ordine apparentemente casuale ed è proprio questo che ha fatto pensare a De Pasquale e Onorato che si tratti di un codice.
Dopo alcuni tentativi i due storici dell’arte hanno davvero scoperto un codice: le lettere ricorrenti sui blocchi di pietra rappresentano infatti le sette note musicali, che insieme creano un concerto di circa tre quarti d’ora in stile gregoriano per strumenti a corda. Il tema della musica in realtà non è estraneo all’edificio poiché sembra che ai tempi in cui la chiesa era ancora Palazzo Sanseverino, ci fossero alcune decorazioni di simboli musicali.
La partitura, soprannominata “Partitura Enigma”, è stata in seguito ricostruita grazie al lavoro di due studiosi ungheresi, il musicologo Lòrànt Réz e l’esperto di aramaico, il gesuita Csar Dors. Il concerto viene oggi suonato con l’organo, una melodia apparentemente persa nello scorrere del tempo ma che è in realtà è sempre stata lì, invisibile agli occhi di coloro che ignari posavano gli occhi su di essa.